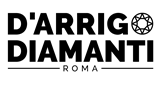Prima di passare alla lucidatura gli oggetti devono essere liberati dai resti di tutti gli abrasivi delle precedenti operazioni di levigatura. Se infatti rimane sugli oggetti un residuo di abrasivo come il sassomarcio, che, oltre a non essere adatto alla lucidatura, possiede anche una grana, insieme all’azione di scorrimento prodotto dal rossetto, si produrrebbero dei nuovi piccoli solchi e la lucidatura finale non sarebbe la migliore.
Come dice la parola, sgrassatura significa allontanamento dei grassi e in genere dello sporco. Per giudicare se un oggetto è sgrassato basta immergerlo in acqua. L’oggetto bene sgrassato tolto dall’acqua appare bagnato in ogni sua parte.
Si sgrassa come fase di preparazione:
- alla saldatura;
- alla finitura;
- alla finitura Galvanica;
- alla smaltatura;
- la finitura nera;
- alla coloritura;
- all’imbianchimento.
La sgrassatura può essere eseguita:
- a spazzola con soluzioni acquose calde;
- con solventi con o senza ultrasuoni;
- soluzioni acquose calde;
- con soluzioni acquose calde e ultrasuoni;
- per via Galvanica.
L’ultimo metodo può trovare utile applicazione nell’officina orafa come mezzo generale di preparazione anche se l’oggetto non deve essere sottoposto a trattamenti galvanici.
Sgrassatura spazzola
Il metodo più vecchio della sgrassatura a spazzola è quello che impiega la calce spenta dei muratori. Non deve essere invecchiata a meno che non sia conservata in recipienti chiusi. Per ottenerla si può partire dalla calce viva in pezzi facendo cadere poca acqua in modo che nel reagire non si produca palta. Conservata al riparo dall’aria è sempre pronta. Questo vecchio metodo può ancora essere utile in alcuni casi speciali come preparazione a qualunque finitura.
Nella gioielleria questo metodo non è applicabile perché l’oggetto verrebbe a perdere l’aspetto levigato e lucido che deve avere. Si ricorre perciò alla spazzolatura con altri prodotti che non hanno questo inconveniente. È’ possibile adoperare il sapone che ha notevole proprietà emulsiva soprattutto se viene associato all’azione meccanica della spazzola per cui i grassi aderenti al gioiello tendono rapidamente a passare in sospensione.
L’azione della spazzola è indispensabile per rimuovere meccanicamente le sostanze grasse. Sono comunque utilizzabili anche i preparati consigliati per uso domestico.
L’industria fornisce vari tipi di spazzole più o meno adatte alle dimensioni e alla conformazione degli oggetti. In molti casi si può adoperare sia una spazzola che un’altra.
Sgrassatura con solventi
Nella scelta di un solvente si considerano la convenienza economica, l’efficacia, la volatilità, la pericolosità. Sono disponibili tabelle con dati di infiammabilità e di tossicità.
Nelle lavorazioni industriali in genere sono stati abbandonati i solventi infiammabili come solfuro di carbonio, benzina, petrolio, per altri meno pericolosi. Vecchi solventi sono l’alcol, usato per sciogliere la gommalacca e nella vecchia lucidatura dei mobili, l’acqua ragia per l’olio di lino usato nella verniciatura e nella pittura. Meno antichi sono il petrolio, la benzina, l’etere di petrolio, l’etere, efficaci per sciogliere grassi, oli, cere… La tossicità è un altro pericolo presentato in misura maggiore o minore dai solventi.
Sono studiate sostanze nuove allo scopo di rendere sempre meno pericolosa la permanenza negli ambienti di lavoro.
Il maggiore successo si è avuto nello scoprire i solventi non infiammabili. Non altrettanto è stato possibile fare per la tossicità. Ossia è scomparso o quasi il pericolo di saltare per aria ma è rimasto quello di andare all’ospedale per avvelenamento, talvolta anche mortale.
Il progresso tecnologico moderno ha costretto anche l’oreficeria ad impiegare in quantità sempre maggiori i solventi. Il loro impiego è nell’asporto dei grassi, prima ottenuto per emulsionamento acquoso saponoso oppure con petrolio caldo. Uno dei primi solventi non infiammabili è stato il cloroformio, quello adoperato in medicina. E’ noto che è un eccesso di cloroformio poteva divenire pericoloso e che un medico doveva sorvegliare continuamente le condizioni del paziente. Questo è un esempio fin troppo palese che il chimico se da un lato ha reso un solvente non infiammabile dall’altro non l’ha potuto rendere innocuo.
Purtroppo questo è valido per tutti i solventi non infiammabili. Perciò, quando in un’azienda un solvente viene impiegato non in modo saltuario e per breve tempo, bisogna attrezzarsi per allontanare i vapori.
L’industria ha messo a punto vasche riscaldate con cappe, aspiratori, serpentine di raffreddamento di modo da garantire l’innocuità del lavoro in impianto unico. Ecco un breve elenco dei solventi più comuni che possono interessare l’oreficeria.
Un solvente che ha preso in questi ultimi decenni largo impiego è la trielina, detta anche in modo abbreviato <>; altro suo nome è tricloroetilene. È’ uno dei solventi più economici comunemente usato per la sgrassatura a secco degli abiti nelle lavanderie. Un litro Pesa1470 g. Bolle a 78°C. Ha un odore cloroformico caratteristico. È’ velenoso se ingerito allo stato liquido e se respirato a lungo può indurre sonnolenza. Siccome ha massa volumica superiore all’acqua di quasi il 50%, può essere conservato sotto di questa. Ha un notevole potere solvente per grassi, cere, e alcuni colori.
Ha anche un inconveniente non sempre considerato nella sua gravità. I suoi vapori se vengono a contatto di corpi roventi o di fiamme, si decompongono svolgendo acido cloridrico gassoso irritante, tossico e corrosivo.
Questi vapori possono perciò favorire la corrosione dei macchinari. Per la stessa ragione i materiali ferrosi sgrassati con trielina tendono facilmente ad arrugginirsi. È’ possibile scoprire facilmente se una trielina è alterata. Si prende un batuffolo di cotone idrofilo, lo si imbeve della trielina sospetta e si espone a qualche centimetro di distanza dall’imboccatura di un recipiente contenente ammoniaca. Se la trielina è più o meno decomposta si vedrà sollevarsi del fumo bianco che parte dal batuffolo. Per ritardare questa alterazione l’industria chimica aggiunge alla trielina prodotti stabilizzanti.
Si consiglia di mantenere nei recipienti dov’è contenuto il liquido marmo in polvere o in graniglia. In conseguenza dell’ alterazione della trielina l’industria ha proposto l’impiego gli altri prodotti ancora non infiammabili, con grado di tossicità troppo diverso come ad esempio il tetracloruro di carbonio bolle a 77° C e ha massa volumica 1,594.. Anche questo tende a decomporsi in presenza di vapore d’acqua.
Un prodotto molto più stabile è il percloroetilene. Massa volumica 1,624. Bolle a 125° C. È un prodotto più stabile ma più costoso e ha un punto di ebollizione più elevato. Lo si trova facilmente in commercio anche il nome tetracloroetilene. Più recente è il clorotene . Si ritiene che i suoi vapori siano meno tossici. In alcuni casi si usa ancora il cloroformio detto anche <>. Esso è particolarmente consigliato per asportare alcune materie plastiche come il plexiglass usato nella falsa gioielleria. I solventi sono il salicilato di metile, l’acetato di amile ed altri eteri misti.
Tutti i solventi in questi anni hanno ricevuto più attenzione perché il loro potere può essere migliorato dall’applicazione contemporanea del riscaldamento e degli ultrasuoni. Bisogna però non trascurare che ambedue queste variabili rendono più facile l’uscita di vapori nell’ambiente, quindi rispettare le norme di sicurezza sul lavoro.
Sgrassatura in vapori solventi
I solventi liquidi hanno limitazione alla loro efficacia. Man mano che sciolgono lo sporco aderente ai corpi, lo trattengono e perdono perciò la proprietà di sgrassare. Occorrerebbe usare sempre nuovo solvente.
L’industria ha superato questa limitazione con la costruzione di impianti utilizzano una proprietà fisica delle miscele liquide. Il vino contiene soprattutto acqua ed alcool che bollono a temperature diverse. In conseguenza riscaldando si sollevano prima i vapori di alcool. Solo dopo l’espulsione dell’alcool, la temperatura sale fino all’ebollizione dell’acqua.